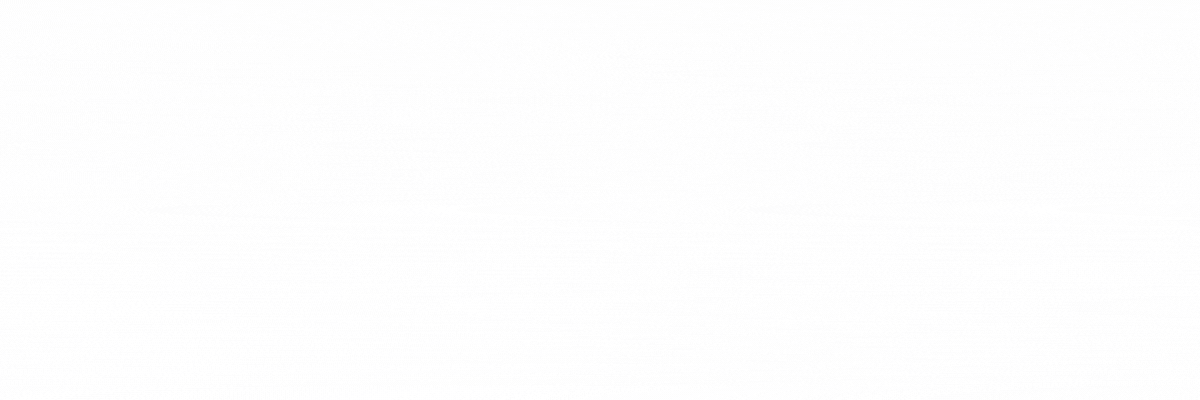di Tonino Armata
SAN BENEDETTO – Nel campo c’era una famiglia muta. Padre, madre e due bambini. Erano inerti. Non chiedevano nulla, neanche da mangiare, e non c’era modo di capire cosa fosse accaduto. Si era tentato di tutto, senza successo. Erano intervenuti poliziotti, psicologi, un imam. Ma loro niente. Avevano valicato le montagne con la prima neve, ed erano arrivati denutriti dopo chissà quanti giorni di cammino. Ma era da un mese che si erano chiusi nel silenzio. Fluttuavano come fantasmi, non mostravano emozioni, non pregavano, non piangevano, non ridevano. I figli — tre e dieci anni — non giocavano. Erano un inestricabile, impressionante groppo di negatività.
Una volontaria me ne parlò e si decise di andare sul posto. Tirava vento, il campo profughi era uno sterminato pantano e non fu facile trovare la tenda. All’interno c’era solo il bimbo più piccolo, raggomitolato nelle coperte. La donna si sedette a terra e se lo coccolò. Gli porse un dolcetto di sesamo, ma lui niente.
Gli regalai un rosario laico greco, un portafortuna. Lo prese tra le mani, lo osservò a lungo. Ma intanto mormorava qualcosa, come un mantra. Due nomi maschili: Adil, Isaam. Li ripeté a lungo. Forse era il segnale. Arrivarono i genitori, la volontaria li salutò guardandoli intensamente negli occhi, poi ripeté quei nomi a bassa voce, oscillando col corpo come chi prega. Adil Isaam, Adil Isaam, Adil Isaam.
Fu così che la storia emerse dalla bocca dell’uomo, in un racconto privo di apparente emozione. La voce sbloccata era il brivido di una foresta scossa dal vento. La moglie aveva scolpito in viso lo strazio di Maria sotto la croce. Gli avevano incendiato la casa, ed erano fuggiti tutti verso il Pakistan, attraverso la grande montagna. «Tutti vuol dire quanti?», chiedemmo. Lui disse «Sei. Noi e i nostri quattro figli». Adil e Isaam erano quelli mancanti. Maschi anche loro.
Qui la storia si addentra nel territorio dell’indicibile. I sei salgono a fatica. Il piccolo di tre anni dorme sulle spalle del padre. Il più grande ha ancora abbastanza forza. Ma i figli di mezzo soffrono per la marcia interminabile e le notti all’addiaccio. Adil, cinque anni, e Isaan di sette. Arriva la neve. Mamma e papà capiscono che quei due non ce la faranno mai e che a causa loro l’intera pattuglia rischia di fermarsi e morire.
È tardi per tornare indietro e la montagna è battuta da cani pastori enormi e affamati. I genitori non si parlano, ma si capiscono al volo. È la legge della sopravvivenza. L’inverno da quelle parti è spietato e bisogna lasciare per strada chi non ce la fa. Ma non hanno cuore di abbandonarli. Allora papà li accompagna sull’orlo di un dirupo, mostra le montagne, dice che oltre c’è la salvezza, dà loro una caramella. Poi li precipita nel burrone. Morti all’istante, sfracellati. E quando, giorni dopo, le guardie di frontiera li trovano, i superstiti sono già creature dell’altro mondo, senza più occhi, senza più lacrime.
È accaduto vent’anni fa, al confine fra Afghanistan e Pakistan, sui monti dell’Hindukush. La famiglia proveniva dal Nuristan, il campo profughi era vicino a Islamabad e la volontaria che infranse quel silenzio tombale era la figlia di un generale e si chiamava Gulmina Bilal.
Ho aspettato vent’anni per raccontare questa storia, così vicina al film La scelta di Sophie, dove una donna ebrea, all’arrivo nel campo di sterminio, è obbligata da un ufficiale delle SS a scegliere in pochi secondi quale dei due figli destinare alla camera a gas. Qui è persino peggio. C’è un padre costretto a sopprimere due dei suoi bimbi con le sue mani, e a portarsi per la vita il rimorso del suo atto.
Oggi capisco che è stato lì, in quel campo, che il dramma dei rifugiati si è saldato per sempre con quello dell’Olocausto, ed è stato lì che mi è apparso chiaro il ruolo del silenzio nella rimozione degli orrori. Silenzio degli aguzzini, dei bempensanti, della politica. Silenzio delle Ong, tenute sotto ricatto nel loro lavoro in prima linea.
Ed è paradossale che anche chi ce l’ha fatta sia complice di questo oblio. I fantasmi arrivano in Italia, increduli e spaesati, ti sfiorano, finiscono in quarantena e si dissolvono nuovamente. Raccontano poco e vogliono dimenticare. Ricordo un afghano, aveva il corpo pieno di schegge di una mina antiuomo. Si lasciò aiutare e poi scomparve. Pochi giorni fa è venuto a bussare a una comunità- asilo per minori un bambino iracheno solo, di sei anni.
Non sapremo mai la storia di questa gente, l’ho imparato da piccolo. La seconda guerra mondiale era appena finita, a casa mia si organizzavano feste in continuazione, e in quelle baldorie il più scatenato, il più acchiappa- femmine, il più inesauribile narratore di barzellette era un ebreo sopravvissuto ai campi nazisti. Come avrei potuto capire cosa era appena successo? Ma la memoria conosce strani sentieri di ritorno e si attiva per analogie.
Negli anni Novanta i Bosniaci in fuga mi aiutarono a capire l’esodo istriano del dopoguerra. E oggi, da quando è emersa la storia dei migranti nella morsa dell’inverno dei Balcani e vedo passare per il Carso altri fantasmi muti, da quando vedo impugnare il vessillo di Cristo per respingere poveri Cristi, ecco che la crocefissione di quella famiglia muta a Islamabad torna a galla con prepotenza per essere narrata e illuminare il tutto. Oggi, se incontro un migrante, non esito. Lo aiuto con quello che ho. Un letto, denaro, cibo, vestiti. E sono in tanti a farlo in silenzio, non solo per dovere civile, ma per disobbedire a una legge infame, che un giorno potrebbe trasformare in reato anche la carità.
Dallo sterminio degli Ebrei a oggi è un’unica storia. Quando vedo reticolati, cani lupo e mucchi di vestiti abbandonati nei boschi, quando un assessore comunale butta nella spazzatura le coperte di un barbone o c’è un migrante disperato che si toglie la vita, dico che non me ne importa niente che fra vent’anni noi si istituisca un altro Giorno della Memoria per salvarci l’anima, ricordando queste vittime a tragedia finita.
L’Italia è circondata di morti, in terra e in mare. Oggi, non ieri. Però è l’unico paese d’Europa a vantare non uno ma due giorni della memoria; e questo non tanto per chiedere scusa ma per farsi chiedere scusa. Dai popoli slavi per le foibe e dai Tedeschi per le vittime della Risiera. Italiani brava gente, sempre.
Solo un Paese che non ha fatto i conti con la storia, solo una nazione che negli ultimi vent’anni ha demolito il senso del “noi” e distrutto welfare e solidarietà, può consentire il saldarsi nelle piazze italiane di un popolo di intolleranti, negazionisti e forcaioli, bloccare navi-soccorso per settimane in mare, o permettere alle forze dell’ordine, come è accaduto in ottobre, di manganellare un sit- in di protesta di volontari radunati per soccorrere migranti sfiniti.
Due pesi e due misure. La stessa polizia che vanta il suo attivismo sulla frontiera, non riesce — anche per la falcidia degli organici — a impedire assembramenti da bar a pochi metri dalle questure. Pericolosi focolai di epidemia, accesi in barba ai decreti ministeriali.
Il mio confine a Nordest è da sempre al centro di questa epopea. È da tempo che vedo passare genti in fuga. Istriani, Curdi, Africani, Bosniaci, Afghani, Iracheni, Siriani. Un esodo biblico, ininterrotto, crescente. Oggi, loro ci sono entrati in casa, scuotono le nostre coscienze, si saldano al dramma dei nostri terremotati e dei nostri emigranti di ieri e di oggi. Bisogna essere ciechi per non vederli. Sull’asfalto i fari li illuminano. Sbucano dall’inverno con donne e bambini piccoli. E quando scatta il coprifuoco da Covid e le strade si svuotano, a popolare la città sono quasi sempre loro, in bicicletta, carichi delle vivande calde per le nostre mense.
Non possiamo più dire di non sapere. L’esistenza dei campi è documentata in diretta da giornali e tv. Ma ciò che accade fuori da quei lager timbrati Ue resterà imprigionato a lungo nel regno dell’indicibile, come l’Esodo degli istriani, un arcipelago di memorie divise per paesi, dove spesso i padri non hanno saputo comunicare l’accaduto nemmeno ai figli. Non si sa, e se si sa ci si abitua.
Siamo diventati indifferenti. Quando quarant’anni fa furono trovati quattro figli dell’Africa Nera congelati sulla stessa strada battuta oggi dagli afgani, fu data loro onorata e pubblica sepoltura, e ai funerali parteciparono i maggiorenti della municipalità. Oggi non ci si volta indietro. E c’è il Covid a sdoganare l’indifferenza.
Degli Ultimi sappiamo storie a lieto fine. Delle altre, poco o nulla. Dei maschi cui la polizia croata spezza le gambe. Dei paramilitari che organizzano battute di caccia all’uomo. Dei dispersi nel gelo. Delle polizie in combutta con le mafie. Dei manganelli elettrici dei Bulgari. Dei respingimenti in furgoni senza finestre. Di quelli che hanno tentato trenta volte di passare. Della speranza che muore. Non è roba che vedi in tv.
Nei campi alle porte dell’Italia ora c’è la neve, e la neve fa notizia. Ma poi verrà il fango, e dopo il fango i bucaneve, e allora non se ne parlerà più. Dei campi greci sappiamo degli incendi, ma pochi sanno dei giovani poliziotti (quattro, cinque?) che l’anno scorso si sono suicidati in quei campi perché non potevano resistere all’orrore. Temo che non ci sarà nessuno Spielberg a raccontare questa tragedia. Forse, il vento è la sola voce. onesta della storia.